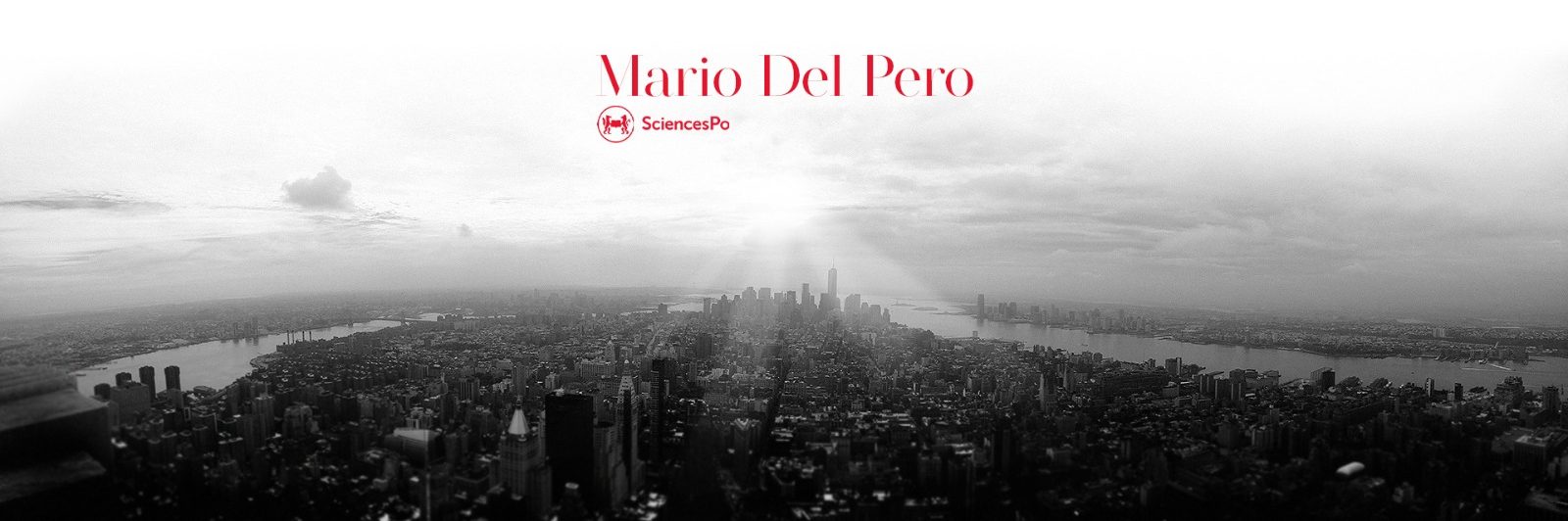Si chiude dopo più di un decennio la saga di Julian Assange. Il giornalista fondatore di Wikileaks ammette la propria colpevolezza per un singolo reato di acquisizione e diffusione di documenti secretati. La pena è di fatto già stata scontata durante i cinque anni di detenzione nel Regno Unito e Assange può tornare da uomo libero nella sua Australia. L’opinione pubblica, in Europa e negli Stati Uniti, si divide tra chi celebra l’uomo libero e coraggioso capace di sfidare il potere, esponendone i misfatti e i crimini, e chi accusa l’hacker spregiudicato che viola le leggi e finisce per colludere con i nemici dell’Occidente, Russia su tutti.
La verità, se ve ne è una, sta probabilmente nel mezzo. Ovvero si colloca in una zona grigia, dove domina una strutturale opacità che impedisce di tracciare confini netti e inequivoci. È, questo, lo spazio del segreto di Stato, indispensabile al funzionamento di qualsiasi sistema democratico, che di esso abbisogna per poter operare e proteggersi, ma che spesso ne abusa per occultare eccessi, illeciti e abusi. Ma è anche lo spazio in cui operano giornalisti che nel pretendere di esporre un potere fuori controllo – e in nome di una concezione assai larga della libertà di parola e di stampa – talvolta rivendicano il diritto d’infrangere la legge, senza prestare attenzione alcuna alle conseguenze politiche e materiali.
Julian ha in fondo catturato l’immaginario di noi osservatori perché ha incarnato e sublimato questa opacità e le sue mille contraddizioni. È stato il “whistleblower“, l’ultimo di una lunga e nobile tradizione di informatori, che ha disvelato le nefandezze della politica internazionale e del suo attore principale, gli Stati Uniti: le sistematiche violazioni di basilari diritti civili e umani giustificate dalla guerra globale al terrorismo; l’inosservanza dei fondamenti del diritto internazionale e di guerra in Afghanistan e Iraq; la capillare e intrusiva azione di spionaggio ai danni di cittadini statunitensi o contro gli stessi alleati di Washington; e tanto altro ancora. Ma è stato anche il giornalista che non ha rispettato le più elementari norme di trasparenza e privacy, utilizzando pratiche di hackeraggio “quantitative” che catturavano e rendevano pubblici tutti i documenti possibili senza prestare attenzione ai loro contenuti; che ha diffuso i veleni di tante teorie cospirative; e che ha finito per aiutare di fatto Donald Trump nella campagna del 2016, operando – consapevolmente o meno – con l’aiuto dell’intelligence russa.
A monte agiscono due problemi di fondo, strettamente interrelati e anch’essi incarnati dalla figura e dalla storia di Julian Assange. Il primo sono gli standard duali che gli Stati Uniti applicano e rivendicano nella conduzione della loro politica estera. L’idea che regole e norme si applicano agli altri e non a sé stessi. Questi standard Assange ha denunciato ed esposto, finendo però per essere in ultimo catturato da un’ostilità a Washington (e alla leadership democratica) che da un certo momento in poi è parsa costituire la motivazione principale del suo agire. Con un paradossale cortocircuito, la denuncia dei doppi standard statunitensi è diventata giustificazione dei doppi standard di Assange. Il secondo problema è l’abuso del segreto di Stato, paradossale conseguenza tra l’altro, dell’eccesso di diffusione di questi segreti non solo tra le agenzie governative ma anche tra i tanti soggetti privati cui vengono subappaltati funzioni e compiti delle politiche di sicurezza nazionale. Troppi segreti in mano a troppe mani, nelle forme di comunicazioni elettroniche come quelle contemporanee, facilitano azioni di hackeraggio indiscriminato come quelle compiute da Assange e dalla sia Wikileaks. All’abuso del secreto corrisponde la generica non selettività della sua esposizione.
Anche per questo più che eroe o criminale, martire o delinquente, Julian Assange è solo il simbolo dei tanti cortocircuiti di un’epoca in cui alla realtà della secretazione e archiviazione discrezionale ed eccessiva di milioni di fonti è corrisposta l’illusione che qualcuno, addirittura un singolo eroe, fosse davvero capace di usare il web per denunciare e combattere tutto ciò.
Il Giornale di Brescia, 27 giugno 2024